![]()
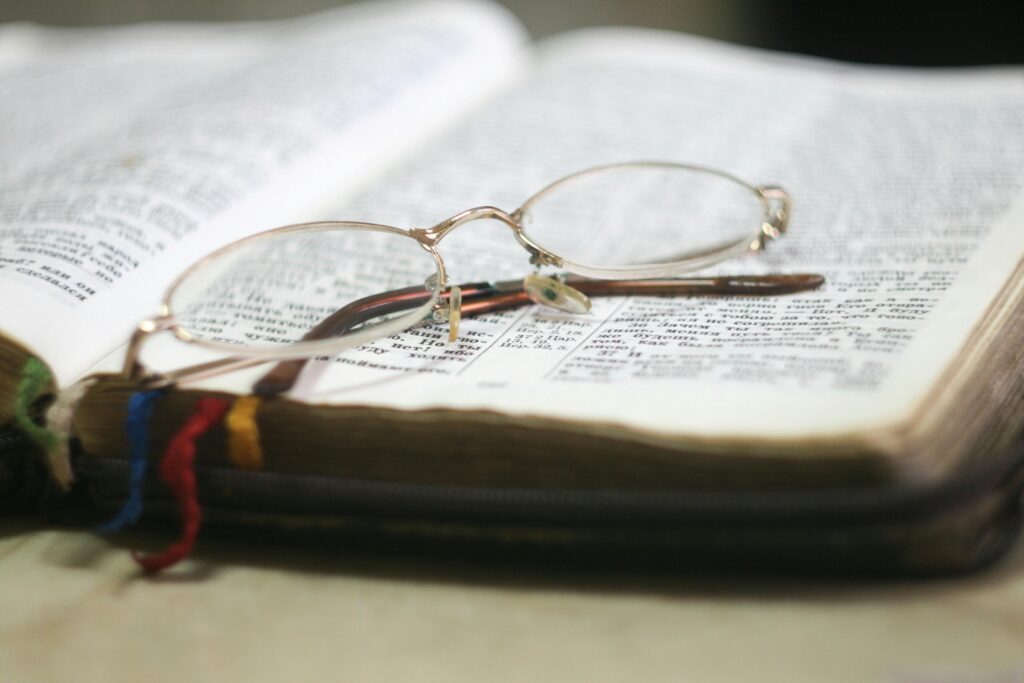
Gli atti degli Apostoli (13,14,43-52), da cui è tratta la prima lettura di oggi, ci presentano Paolo e Barnaba nel loro primo viaggio missionario da Perge ad Antiochia, lungo circa 150 km.
Giunti nella sinagoga, il testo riferisce: “Sedettero”. L’espressione ci conferma quanto immaginato, di un viaggio alquanto faticoso e difficile, dopo il quale si rendeva necessario sedersi a riposare; tuttavia, iniziano a intrattenere subito i proseliti invitandoli ad ascoltare la parola di Dio. Il nucleo della liturgia della parola odierna è rappresentato dall’ascolto e dalla relazione. Il primo passo di chi vuole partecipare consiste nel radunarsi attorno a Paolo e Barnaba, il secondo appunto nell’ascoltare.
Sarà stato tanto appassionante e denso di fede il discorso tenuto dai discepoli che i Giudei, riconoscendo la loro fragilità argomentativa, si ingelosiscono; le loro comode verità vengono rimesse in discussione dalla limpidezza del messaggio evangelico, preferiscono non ascoltare per non mettere in crisi le proprie certezze autoreferenziali e allontanano gli apostoli dalla sinagoga.
L’ascolto dunque causa divisione tra chi sceglie la “buona novella” e chi rimane ancorato alla propria visione, ma nello stesso tempo la Parola è generativa di nuovi cammini e nuovi orizzonti. È profetico il verso di Isaia (55:10-11) “ … Così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca: essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero”.
Da questo momento il messaggio apostolico diviene ecumenico, perché Paolo e Barnaba si rivolgono allora ai pagani. Anche a loro era destinata la Parola e da essi viene accettata gioiosamente. I due apostoli continuano ad evangelizzare per tutta la Pisidia tanto che vengono perseguitati dai ceti nobili delle città, e saranno presto costretti ad andare via “scuotendo la polvere dai piedi” proprio aveva predetto Gesù nel vangelo di Matteo (10,14):
“E se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi”, espressione tipicamente ebraica che indica la presa di distanza da chi ha rifiutato il messaggio, e al tempo stesso la volontà di andare comunque avanti e di non lasciarsi influenzare dalle difficoltà incontrate.
C’è in questo primo viaggio missionario, che vede due apostoli camminare e predicare insieme, un ulteriore riferimento all’invio dei suoi discepoli da parte di Gesù. Nel vangelo di Luca (10,1) si legge: “Gesù designò altri 72 apostoli e li inviò a due a due”. Gesù vuole sottolineare la necessità della condivisione e della relazione. In due ci si può aiutare, ci si può correggere vicendevolmente, si può riflettere e imparare l’uno dall’altro. Anche nel metodo dell’evangelizzazione, Gesù preferisce la collaborazione e lo scambio reciproco ad un’autoreferenzialità tanto simile alla auto-proclamazione.
E forse non è un caso che anche nel salmo l’invito sia rivolto al plurale: “Acclamate il Signore voi tutti della terra servite il Signore nella gioia presentatevi a lui con esultanza”(Salmo 99).
Il tema dell’ascolto e della relazione diviene più evidente nel vangelo di Giovanni (10,27-30): “Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi seguono”. Risuona il richiamo di Mosè: “Ascolta Israele, il Signore ha stabilito con noi un’alleanza” (Esodo 20,1-17), nuova e unica per ciascuno, Lui ci conosce e quindi ci ama (nel linguaggio biblico il verbo “conoscere” indica una comunione d’amore). E così, ascoltando la sua voce, lo seguiamo per realizzare la grande alleanza promessa ad Israele, resa viva e presente dal sacrificio di Dio per gli uomini.
L’alleanza con il buon pastore è la promessa salvifica di una vita eterna, nuova e luminosa, capace di trasfigurarci come Gesù sul monte Tabor. A noi è rivolta la visione di Giovanni nell’Apocalisse: “Avvolti in vesti candide, non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, sarà il loro pastore, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi (7,9 14-17)”

Lascia un commento